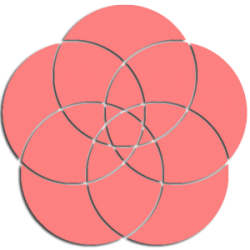Recensione del libro di Terada Torahiko, Lo spirito dello haiku, Torino, Lindau, 2017, pp. 64 (traduzione e cura di Marco Taddei).
 L’edizione che viene qui presentata al pubblico italiano raccoglie due fondamentali contributi all’approfondimento della poesia haiku da parte di Torahiko Terada (1878-1935), noto fisico e scrittore giapponese, già professore all’Università Imperiale di Tokyo e al Tokyo Daigaku Jishin Kenkyu-jo: lo Haiku no seishin 俳句の精神 (“Lo spirito dello haiku”) del 1935 e il “diario” letterario Natsume Sōseki sensei no tsuioku 夏目 漱石先生の追憶 (“Ricordi del professor Natsume Sōseki”) del 1932.
L’edizione che viene qui presentata al pubblico italiano raccoglie due fondamentali contributi all’approfondimento della poesia haiku da parte di Torahiko Terada (1878-1935), noto fisico e scrittore giapponese, già professore all’Università Imperiale di Tokyo e al Tokyo Daigaku Jishin Kenkyu-jo: lo Haiku no seishin 俳句の精神 (“Lo spirito dello haiku”) del 1935 e il “diario” letterario Natsume Sōseki sensei no tsuioku 夏目 漱石先生の追憶 (“Ricordi del professor Natsume Sōseki”) del 1932.
Nella prima parte del libro l’autore sviluppa ed approfondisce le proprie teorie sulla struttura e sull’estetica dello haiku, partendo dal peculiare rapporto che il popolo giapponese ha sempre avuto con la natura (shizenkai 自然界), rapporto lontano – anzi, diametralmente opposto – a quella visione utilitaristica e distaccata propria del mondo occidentale, la quale tenta di addomesticare la natura stessa asservendola ai più vari ed individualistici scopi.
Così, secondo l’autore, per poter comprendere appieno l’ampiezza dell’esperienza che deriva dallo haiku, occorre innanzitutto «conoscere lo spirito del popolo giapponese» e quell’intima connessione che lega l’individuo alla realtà circostante e alle molteplici declinazioni attraverso cui questa trova manifestazione, specie alla luce delle particolari condizioni ambientali che ne hanno favorito lo sviluppo; in tale contesto, menziona alcune espressioni come harusame 春雨 (“pioggia primaverile”) o akikaze 秋風 (“vento d’autunno”) le quali, lungi dall’esaurire il proprio significato nella rappresentazione di fenomeni metereologici, recano un’etimologia (rectius, un “significato originario” o hon’i 本意) socio-culturale e spirituale direttamente riconducibile alla storia del Paese, rievocando le gioie e le sofferenze dell’intera “stirpe di Yamato”, e che nello haiku trova la più nobile forma di perpetuazione.
Unitamente alla caratteristica brevità che la contraddistingue, ne consegue che, in questa forma poetica, ogni singola parola dev’essere soppesata con estrema cura, giacché in grado di influenzare irreversibilmente lo spirito poetico sottostante, in una sorta di “magia” (jujutsu 呪術) che è al contempo potenzialità evocativa (derivante dal suggerire una determinata lettura piuttosto che enunciarla) e associazione immaginifica.
L’autore mette tuttavia in guardia il lettore dal giungere a conclusioni affrettate. Se è vero che la relativa limitatezza di parole a disposizione dello haijin 俳人 e l’altrettanto relativa “rigidità” formale – data dalla struttura poetica in tre momenti (ku 句) e diciassette “sillabe” (rectius, on 音) – potrebbero portare a credere che questa forma poetica sia presto o tardi destinata ad esaurire le proprie potenzialità espressive, in favore di costruzioni più libere e “generose”, «il contenuto spirituale e morale che essa veicola non smette di evolversi», adattandosi quasi per dote evoluzionistica alle molteplici interconnessioni tra uomo e natura e alla società, modellando il senso profondo delle cose analogamente a un liquido che viene versato ogni volta in un nuovo recipiente.
Sempre nello Haiku no seishin, Terada si poi sofferma ampiamente sull’aspetto prettamente strutturale dello haiku, e in specie sullo schema metrico, il quale, lungi dal costituire una limitazione espressiva o un vincolo al libero dispiegarsi del sentire poetico, diviene per contro canone distintivo del genere:
Se la poesia breve manca di una forma fissa, è difficile distinguerla da un appunto su un taccuino.
L’alternanza di 5 e 7 on nella poesia giapponese deriva, in fin dei conti, da un’evoluzione ritmica e funzionale che gli autori del passato hanno più volte confermato essere “inevitabile”, in quanto talmente radicata nel registro linguistico del Sol Levante da sostanziare un processo del tutto analogo a quello della selezione naturale:
Il ritmo fondamentale 7-5 non è stato creato da qualcuno ma è nato da solo e da solo si è sviluppato.
L’autore pone infine l’accento sull’estetica dello haiku stricto sensu, tratteggiando una personale (ma assolutamente condivisibile) lettura dei canoni del sabi 寂 e del fūryū 風流, principi che, sebbene nati in epoca lontana, presentano nondimeno una forza e una tenuta decisamente attuali. Se dunque il fūryū assume i contorni di una libertà d’animo tale da permettere all’individuo-poeta (il fūryūjin 風流人) di liberarsi dai fardelli e dalle fatiche del mondo, il sabi diviene emblema di quella capacità tutta umana di cogliere la pienezza del vivere in ciò che si è e in ciò che si possiede. A tal proposito, Terada propone un processo di formazione dello haiku decisamente vicino a quel cammino di ricerca che abbiamo avuto modo di approfondire nel Fūryū ni kan-suru ikko satsu 風流に関する一考察 (“Una riflessione sul fūryū”) di Kuki Shūzō e che prevede due passaggi essenziali: a) l’allenamento interiore all’osservazione della natura (shizen 自然) e b) l’individuazione e selezione di quegli elementi capaci di assurgere a “simbolo” poetico del legame uomo-realtà, ossia una sorta di labor limae che, tuttavia, rifugge distaccate procedure, ma avviene piuttosto con spontaneità e naturalezza.
Nella seconda e ultima parte del libro, infine, l’autore riporta, in ordine cronologico ma narrativamente libero, una serie di ricordi della propria gioventù in relazione alla frequentazione del liceo Daigo di Kimamoto, e in particolare agli incontri che l’autore stesso ebbe privatamente con il professore di inglese Natsume Sōseki (1867-1916), già scrittore e poeta di una certa fama. Lo sviluppo del contesto espositivo parte dalla definizione di haiku che lo stesso Sōseki diede a Terada («[lo haiku] descrive qualcosa indicandone l’elemento focale e allude all’universo di associazioni che si irradia da quello, come le stecche dal perno di un ventaglio») per rimodellare quasi, con la sola forza della rievocazione, i tratti salienti della propria personalità poetica e non solo, grazie ad un rapporto di amicizia e stima reciproca che avrebbe portato l’autore a pubblicare i propri componimenti sulla rivista Nippon e, parallelamente, Sōseki a trarre da quel legame ispirazione per la stesura delle proprie opere (come, ad esempio, il romanzo Sanshirō 三四郎 del 1908). Un reciproco sviluppo (letterario e individuale) a tratti commovente, che riesce a coinvolgere il lettore più di quanto quest’ultimo possa immaginare, a chiusura di una pubblicazione che merita decisamente l’attenzione di chi, esperto haijin o neofita, intenda rivelare le molteplici sfaccettature che il termine haiku porta con sé:
Ho imparato molte cose dal Professore. Non solo ho appreso l’arte del comporre haiku ma anche come scoprire con i miei occhi la bellezza della natura […].