 Com’è noto, il kireji 切れ字 (letteralmente, “carattere che taglia”) rappresenta lo stacco tra immagini o concetti giustapposti, una pausa/cesura atta a creare un effetto di sospensione, ammirazione o coinvolgimento con il qui e ora naturalistico. Alla soglia «tra il livello semantico e quello musicale-sonoro» (Iarocci), il kireji è elemento essenziale nella composizione di un buon haiku. Nei Paesi anglofoni (in particolare, gli Stati Uniti), il problema della riproduzione di questo elemento sostanzialmente non si pone; alcuni dei più importanti critici e studiosi di letteratura giapponese dell’ultimo secolo come Reginald Horace Blyth (1898-1964), Harold Gould Henderson (1889-1974) e William J. Higginson (1938-2008), infatti, hanno reso lo stacco (kire 切れ) attraverso un uso intensivo dei segni d’interpunzione, ben comprendendo come, in Occidente, le “parole che tagliano” siano fisiologicamente impossibili da trasporre con assoluta fedeltà.
Com’è noto, il kireji 切れ字 (letteralmente, “carattere che taglia”) rappresenta lo stacco tra immagini o concetti giustapposti, una pausa/cesura atta a creare un effetto di sospensione, ammirazione o coinvolgimento con il qui e ora naturalistico. Alla soglia «tra il livello semantico e quello musicale-sonoro» (Iarocci), il kireji è elemento essenziale nella composizione di un buon haiku. Nei Paesi anglofoni (in particolare, gli Stati Uniti), il problema della riproduzione di questo elemento sostanzialmente non si pone; alcuni dei più importanti critici e studiosi di letteratura giapponese dell’ultimo secolo come Reginald Horace Blyth (1898-1964), Harold Gould Henderson (1889-1974) e William J. Higginson (1938-2008), infatti, hanno reso lo stacco (kire 切れ) attraverso un uso intensivo dei segni d’interpunzione, ben comprendendo come, in Occidente, le “parole che tagliano” siano fisiologicamente impossibili da trasporre con assoluta fedeltà.
In Italia, invece, pare che la “questione kireji”, circoscritta essenzialmente all’aut aut “punteggiatura sì/punteggiatura no”, debba occupare un posto di rilievo nelle discussioni all’interno dei vari Gruppi Facebook. Si presta, cioè, molta più attenzione a come rendere graficamente lo stacco che a come comprendere correttamente le tecniche attraverso cui perfezionarlo (torihayashi とりはやし, nibutsu shōgeki 二物衝撃). Così, coloro che ritengono l’impiego dei segni di punteggiatura una “violazione” dei canoni tradizionali giapponesi ammettono poi – paradossalmente – altri artifici letterari, come ad esempio il piccolo kigo, che, giova ripeterlo, è privo di fondamento storico-teoretico (il riferimento stagionale, secondo quanto rimarcato da Seki Ōsuga, trova rappresentazione solo nella kigo 季語 e nel kidai 季題, entrambi radici della più antica ki no kotoba 季の言葉 e del kisetsu no goaisatsu 季節のご挨拶 o “saluto stagionale” presente nello hokku della renga 連歌). Anziché concentrare i propri sforzi critici verso una rivalutazione del dato naturalistico (il cosiddetto “spirito stagionale” o kikan 奇観), dei principi basilari dell’estetica haiku (sabi 寂, wabi 侘, mono no aware 物の哀れ, karumi 軽み, yūgen 幽玄, ecc.) o del fūryū 風流, questi Gruppi pongono categorici divieti ai loro iscritti, come il non utilizzare le virgole, i punti e i trattini, ed incoraggiandoli, al contempo, a far propri altri espedienti formali, come il trattino basso (“_”), l’uso della maiuscola all’inizio del secondo rigo di cesura o l’assenza totale di punteggiatura.
Personalmente, non ritengo vitale la questione. Fintantoché sussiste una stacco ben riconoscibile all’interno dello scritto, infatti, l’autore è libero di adottare la convenzione segnica che più gli aggrada. Conta, cioè, la sostanza e non la forma. Lo stesso Matsuo Bashō ci porta eloquentemente al nocciolo del problema: «È per coloro che non sono in grado di distinguere tra una poesia “divisa” e una “non divisa” che i primi poeti hanno introdotto l’uso del kireji. Se qualcuno colloca una di queste parole all’interno di uno hokku, sette od otto volte su dieci lo hokku verrà diviso. Nei rimanenti due o tre casi, tuttavia, esso risulterà indiviso, sebbene contempli al proprio interno una parola di cesura. Parimenti, esistono hokku che risultano divisi anche se non hanno alcun kireji.» Ciò che intende il Maestro, è che la cesura non dipende dalla sua forma rappresentativa, ma dall’essenza stessa dello stacco, dalla giustapposizione di immagini apparentemente inconciliabili, ricondotte ad unità proprio attraverso lo spirito poetico che pervade l’intero haiku. Maiuscole, virgole, due punti: tutte queste sono convenzioni grammaticali proprie delle lingua occidentali (ricordiamo che la lingua giapponese non pone distinzione tra caratteri maiuscoli e minuscoli e, dunque, anche le lettere maiuscole sono “a rigore” un elemento spurio), ma proprio perché lo haiku occidentale è una trasposizione di quello giapponese (scritto su un unico rigo verticale e 17 on) non è possibile far aderire al cento per cento il nostro registro espressivo a quello dei grandi haijin del passato.
Dobbiamo mediare tra un imprescindibile desiderio di conservazione dei canoni classici e l’esigenza fisiologica di “fare haiku” nella nostra lingua madre, lingua che non contempla un catalogo di termini a valenza “divisoria” (eccettuate, forse, le interiezioni), ma simboli grafici convenzionali atti a conferire tonalità ed espressione al testo, oltre che a svolgere funzioni di pausa e di sintassi.
Allo haijin occidentale (e, dunque, anche a quello italiano) è innanzitutto richiesto di aderire a quel cammino di verità e bellezza (fūga no michi 風雅の道) cui tanta importanza è stata data da Bashō e dalla sua Scuola, per raggiungere quella verità poetica (fūga no makoto 風雅の誠) che è il cuore stesso dello haiku.

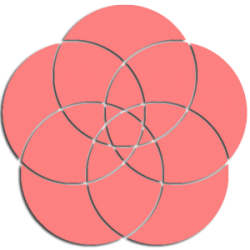
Bravo! Condivido appieno. E non capisco perché tanta attenzione e rigore nella scelta del tipo di stacco – e nel conseguente rifiuto di alternative – quando l’importante è lo spirito di verità e bellezza che porta alla poesia.