 È possibile parlare di “haiku italiani”? La domanda, apparentemente scontata, solleva da sempre, in verità, diverse questioni, relative principalmente alle divergenze culturali che separano il Giappone (terra di origine dello haiku) e, appunto, l’Italia. Io stesso, durante le varie conferenze e presentazioni svolte in questi anni, ho ricevuto le più varie obiezioni, tutte riducibili sostanzialmente all’impossibilità di far aderire completamente ed esattamente lo haiku tradizionale giapponese a quello nostrano.
È possibile parlare di “haiku italiani”? La domanda, apparentemente scontata, solleva da sempre, in verità, diverse questioni, relative principalmente alle divergenze culturali che separano il Giappone (terra di origine dello haiku) e, appunto, l’Italia. Io stesso, durante le varie conferenze e presentazioni svolte in questi anni, ho ricevuto le più varie obiezioni, tutte riducibili sostanzialmente all’impossibilità di far aderire completamente ed esattamente lo haiku tradizionale giapponese a quello nostrano.
Le complessità, invero, esistono e sono evidenti. Innanzitutto a livello formale, laddove lo “stacco” (kire 切れ) che solitamente divide l’opera in due parti, viene generalmente reso in Giappone mediante ricorso ai kireji 切れ字, letteralmente “caratteri che tagliano”. Non si tratta, come in occidente, di segni di punteggiatura (lineetta, virgola, due punti, ecc.), quanto di veri e propri termini che contano nell’economia metrica complessiva dello scritto, essendo ricompresi nel computo “sillabico” (ya や conta infatti un on, kana かな due, e così via) e che conferiscono, al contempo, una certa aulicità all’opera. Ma anche a livello metrico, si rileva una scollatura non di poco conto; posto infatti che il giapponese è una lingua a conformazione parasillabica non accentata, nella quale ciascuna unità fonetica (on 音) presenta invariabilmente la medesima estensione, la sillaba occidentale – nel caso di specie, quella italiana – possiede un’ampiezza vocalica che dipende dalla posizione dell’accento tonico, subendo contrazioni od estensioni a seconda di diversi fattori metrici, non contemplati né contemplabili dalla lingua nipponica. Naturale conseguenza di ciò è che in molti casi, alla lettura, un’opera risulti più breve o lunga di una scritta e recitata in giapponese.
Di più, nello haiku classico ad aumentarne l’evocatività e la sfericità interveniva, quantomeno in passato, il processo stesso di stesura del componimento, laddove il poeta, impugnando il pennello, lo faceva scorrere sulla carta dando forma ai singoli caratteri e trasferendo, al tempo stesso, il proprio portato emotivo in tale gesto, che a seconda della situazione poteva essere incerto e tremulo, rapido, nervoso, ampio, e così via. Insomma, la “via della poesia” (kadō 歌道) era anche, allo stesso tempo, “arte della scrittura” (shodō 書道) e viceversa. Non v’è dubbio che ai giorni nostri, con l’avvento dei caratteri mobili, della macchina da scrivere e dei personal computer, anche molti autori giapponesi adottino un processo più “meccanico” – e meno ricercato – nella stesura delle proprie opere; tuttavia, a garantire una maggior ampiezza semantica permane un modello di scrittura (quello ideogrammatico) profondamente evocativo e flessibile (si pensi a quei caratteri che possiedono più significati), in quanto legato al concetto di simbolo (la “sfoglia” di simboli di cui parla Roland Barthes) e non di convenzione. Come rimarcato da Yves Bonnefoy (1923-2016), infatti, «il segno verbale è fondamentalmente arbitrario. La parola “cane” non evoca nulla dell’aspetto fisico del cane [e] pressoché nessun vocabolo somiglia al proprio referente»(1), mentre «la notazione grafica delle parole [giapponesi] è costituita da ideogrammi, da segni che spesso conservano nella loro forma parte dell’aspetto delle cose, e l’haiku è breve, il che permette di coglierne tutti i caratteri con un sol colpo d’occhio»(2).
Ancora, lo haiku giapponese assume una collocazione del tutto peculiare all’interno del foglio che lo ospita, sviluppandosi su un unico rigo di composizione verticale, senza spazi, esaltando così il bianco del supporto ed evocando, anche visivamente, quella dimensione vuota (yohaku 余白) che è punto di partenza e di arrivo dello haiku stesso, laddove lo haiku occidentale – in debito con le prime traduzioni ottocentesce – occupa più spazio e, dunque, centralità.
Le differenze, insomma, ci sono e non sono di poco conto. Per comporre uno haiku in senso stretto dovremmo affidarci alla lingua che ne ha dato i natali, recuperando quella sfericità semantica cui ho accennato in precedenza.
La trasposizione di questo genere poetico in un’altra lingua – anche qui, nel caso di specie, in italiano – è un processo che perde inevitabilmente qualcosa lungo la strada. Dunque, la domanda resta quantomai attuale: è possibile parlare di haiku italiani?
A mio avviso sì, a condizione che vengano fissate preliminarmente alcune precisazioni. La più ovvia è che si tratta comunque di un “adattamento” di una forma poetica straniera, importata in un altro sistema culturale e linguistico, ma della quale vengono conservati comunque diversi caratteri chiave, tra cui il legame con il contesto naturalistico (pur geograficamente diverso), la brevità, la capacità di esaltare le suggestioni attraverso la giustapposizione (armonizzante o di contrasto) tra due immagini distinte, nonché quei canoni estetici – levità (karumi 軽み), sobrietà (sabi 寂), profondità e mistero (yūgen 幽玄), ecc. – che per loro stessa definizione sono universali e, dunque, condivisibili da tutti gli uomini indipendentemente dalla loro nazionalità e origine, sebbene maggiormente radicati nella sensibilità di certe popolazioni rispetto ad altre.
Lo stesso concetto di hon’i 本意 – il “significato originario” tanto importante per una reale comprensione dei riferimenti stagionali – pur essendosi sviluppato in Giappone (legandosi, così, al codice storico e sociale di quella nazione) non è così lontano dalla nostra comprensione. Se è vero che la valenza simbolica di espressioni come harusame 春雨 (“pioggia primaverile”), araumi 荒海 (“mare in tempesta”) o chiru sakura 散る桜 (“cadono i ciliegi”) possono essere colte in tutta la loro pregnanza solo da un giapponese, esistono per contro termini od espressioni stagionali occidentali che un poeta può tranquillamente collegare ad un vissuto storico-sociale italiano; penso a “ginestra” (fiore importante nella società greca e romana ed esaltato dal Leopardi), “foglie d’autunno” (simbolo di fragilità, specie durante la Grande Guerra, così come evidenziato da Ungaretti), ecc. Insomma, anche in Italia è possibile parlare di riferimenti stagionali (kigo) dotati di un “significato vero”, cioè radicato nella storia del Paese.
Per quanto concerne gli aspetti propriamente formali e strutturali, certo il divario tra i due sistemi persiste. Non possiamo contare sul legame intimo e diretto tra parola e sua rappresentazione, non possiamo occupare un sottile spazio verticale al centro della pagina (preferendo una divisione, anche grafica, dei tre ku 句), né ovviare a quello spezzamento di ritmo regolare che avviene fisiologicamente nel momento in cui facciamo ricorso alla lingua nostrana.
Tuttavia, credo lo haiku in lingua italiana possa avvicinarsi allo spirito di quello giapponese più di quanto non si creda, certo più di altri sistemi linguistici, come ad esempio quello anglosassone. Credo, cioè, che sia possibile sviluppare un linguaggio poetico che assuma una valenza simbolica, più che formale, estremante prossima a quella “originale” nipponica, consolidando un legame tra individuo-poeta e contesto naturalistico sincero e non preconcetto, nel quale la circolarità del contenuto – appena abbozzato e, per tale ragione, aperto a diverse interpretazioni – coinvolge attivamente anche il lettore, che da semplice spettatore delle vicende individuali dell’autore diviene a tutti gli effetti coprotagonista, seguendo un percorso parimenti circolare, che parte dalla natura e a questa fa ritorno. Cambiano, in definitiva, il codice linguistico e quello socio-culturale – si passa da quello giapponese a quello italiano – ma restano pressoché invariate le discriminanti di fondo che, se adeguatamente comprese, possono condurre pacificamente all’affermazione dell’esistenza di uno schema universale e, quindi, adattabile a sistemi tra loro diversi.
Sulla base di tali considerazioni, trovo pertanto difficile condividere quanto affermato da Torahiko Terada (1878-1935) nel suo Haiku no seishin 俳句の精神, laddove a fronte di pur legittime e veritiere premesse («la storia dello haiku è anche un modo di conoscere lo spirito proprio del popolo giapponese»(3)) conclude asserendo che «gli stranieri non comprendono lo haiku e, al contempo, la ragione per cui doveva esistere solo in Giappone»(4).
Si tratta, come già detto, di un adattamento, che deve a sua volta – e necessariamente – accompagnarsi ad un cambio radicale di sensibilità e mentalità, posto che «l’arte occidentale trasforma l’“impressione” in descrizione [mentre] lo haiku non descrive mai: la sua arte è anti-descrittiva, nella misura in cui ogni stadio della cosa è immediatamente, caparbiamente, vittoriosamente trasformato in una fragile essenza d’apparizione»(5).
Alle attuali generazioni di poeti italiani, e a quelle che verranno (oltre che, ovviamente, ai lettori), spetta ora il compito di confermare o sconfessare queste mie considerazioni. Le premesse per la nascita di un movimento haiku tutto italiano sono state, a mio avviso, già gettate, mentre la comunità internazionale ha riconosciuto unanimemente il valore di alcune di quelle voci.
I tempi sono maturi e adesso più che mai si avverte la necessità di ricondurre a unità quella frammentarietà di visioni, spesso arbitrarie, che hanno portato alla nascita di centinaia di “micro centri di potere”, specie sui social network.
Note
(1) Y. Bonnefoy, Sull’haiku, O barra O edizioni, 2015, p. 66.
(2) Ivi, p. 51.
(3) T. Torahiko, Lo spirito dello haiku, Lindau, 2017, p. 36.
(4) Ibidem.
(5) R. Barthes, L’impero dei segni, Einaudi, 1984, p. 89.
Immagine: Kitagawa Utamaro (1802)

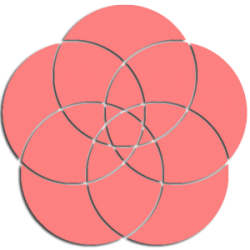
L’haiku è come un aquilone …
L’aiku, la poesia breve, è come un aquilone,
legato con un filo a una mano sapiente.
La cultura, la lingua, le tradizioni sono nella mano.
Ma nessuno guarda il filo e nessuno guarda la mano.
Tutti gli occhi guardano in su a quel segno sempre
più piccolo che si allontana, ammirandone
affascinati, forma, colori, movimenti, sensazioni.
E l’haiku, scusate, l’aquilone volteggia nei cieli,
dall’Oriente all’Occidente.