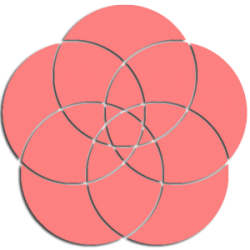Recensione del libro Lirica giapponese classica e poesia greca antica: percorsi ed immagini comuni di Patrick Manuello (Aracne Editrice, 2012, pp. 116, Euro 9,00).
 In questo saggio, l’autore Patrick Manuello – laureato in Letterature e civiltà classiche presso l’Università di Genova – si cimenta in un inedito studio volto ad evidenziare analogie e differenze stilistiche, contenutistiche e culturali tra poesia greca (arcaico-classica ed ellenistica) e giapponese.
In questo saggio, l’autore Patrick Manuello – laureato in Letterature e civiltà classiche presso l’Università di Genova – si cimenta in un inedito studio volto ad evidenziare analogie e differenze stilistiche, contenutistiche e culturali tra poesia greca (arcaico-classica ed ellenistica) e giapponese.
Il testo è suddiviso in cinque capitoli, preceduti da una generosa Introduzione che anticipa alcuni dei tratti distintivi più significativi di entrambi i modelli lirici, come la centralità del mito nella poesia greca o il carattere rappresentativo (e, dunque, non meramente arbitrario e convenzionale) dei segni che veicolano quella nipponica.
In apertura, il Manuello approfondisce i tempi, le circostanze e le modalità di transizione dalla trasmissione poetica orale all’utilizzo della parola scritta, sia in Giappone (a partire dalle influenze culturali cinesi e buddhiste del V secolo d.C.) che in Grecia (con l’introduzione della scrittura alfabetica di origine fenicia nell’VIII secolo a.C.). Vengono così alla luce le prime, importanti differenze; ad una poesia occidentale composta prevalentemente “per l’orecchio” si contrappone infatti una poesia orientale che mira non solo allo spirito, ma anche “alla vista”:
Lo shodō all’interno della Corte Imperiale era tenuto in gran conto perché era considerato lo specchio dell’anima e della personalità di un individuo. Pertanto, l’opera letteraria […] non era soltanto uno strumento di comunicazione, ma pura arte e raffinato piacere estetico (p. 40).
Sebbene waka ed epigramma abbiano in comune, oltre che la brevità, anche l’aggancio alle due grandi tematiche dell’amore e della morte, infatti, è indubitabile il peso che la scrittura ideogrammatica abbia giocato (e tutt’ora giochi) nel più ampio contesto interpretativo del testo giapponese; aspetto ancor più decisivo se si considera la particolare attenzione che i poeti del Sol Levante prestavano ad altri aspetti solo apparentemente marginali, quali ad esempio lo spessore e la qualità della carta oppure la tipologia di ramoscello fiorito che era d’uso accompagnare la lettera contenente il poema destinata alla persona amata. Tutti elementi che la poesia greca non contemplava, se non in via del tutto incidentale, specie dopo l’introduzione dei kalamos.
Nel secondo capitolo, invece, l’autore passa in rassegna i principali testi classici della poesia giapponese, in specie il Man’yōshū 万葉集 (VIII secolo) e il Kokin Wakashū 古今和歌集 (X secolo), sottolineandone non soltanto le differenze stilistiche e strutturali, ma anche – e soprattutto – quelle estetiche. Se quindi da un lato abbiamo un’antologia privata che attinge a piene mani al makoto 誠 (‘parola vera’), ossia ad una modalità di espressione di sentimenti ed emozioni schietta e sincera, dall’altro siamo di fronte a un testo imperiale che ha profondamente rivalutato l’identità autoctona del Giappone attraverso un atteggiamento più moderno e consapevole, fondandosi su un mono no aware 物の哀れ che non corrisponde – come si potrebbe erroneamente pensare – a una malinconica rassegnazione allo scorrere del tempo, ma all’esaltazione della sua bellezza mediante le possibili declinazioni della natura:
Il colore dei fiori
è svanito,
mentre senza scopo
ho passato la vita
fissando la pioggia notturna.
Ono no Komachi (KKS, II:113)
Seguendo questa direttrice interpretativa, dunque, il mono no aware sarebbe parzialmente sovrapponibile alla sympatheia greca, ad un registro poetico capace di procedere parimenti per immagini reali:
Tramontata è la luna
e le Pleiadi; mezzanotte
passa il tempo
ed io sola dormo
Saffo
Poste le basi per un’analisi ragionata e segnate le doverose premesse storiche, si entra nel cuore delle analogie tra poesia giapponese greca nei capitoli III-V.
Nel capitolo III l’autore tratta infatti delle similitudini naturali (ossia quelle che pongono in relazione eventi od elementi appartenenti al mondo naturale e vicende umane) e di quelle afferenti alla dimensione onirica, tracciando anche in questo caso lucidi e credibili parallelismi tra coordinate liriche apparentemente slegate tra loro, come il frammento elegiaco di Mimnermo (VII-VI secolo a.C.) e le waka di Ōe no Chisato (IX-X secolo d.C.) o la poetica sofoclea e quella di Ki no Tsurayuki (872-945).
Nel IV capitolo, invece, viene approfondito il grande tema dell’amore. La waka, da sempre assegnataria di un ruolo “di mediazione” nei rapporti tra uomo e donna nella fase del corteggiamento, trova una radice comune rispetto alla poesia greca in quel senso di insoddisfazione, dolore e disillusione che spesso caratterizza le vicende dei protagonisti. Giuramenti d’amore destinati a restare vane promesse, relazioni non corrisposte e aneliti che travalicano i limiti spazio-temporali rappresentano un ulteriore terreno di dialettica, ma con una precisazione: mentre nella poesia greca classica vi è una maggior “fisicità”, nella waka si assiste ad un’enfatizzazione più marcata dell’immaginazione. Il Manuello propone anche in questo caso dei percorsi intratestuali decisamente interessanti, sostanziando inedite connessioni, come quella che segue:
Da che sento parlare di lei soltanto,
la notte veglio e il giorno
per l’ardore mi sento morire,
come labile rugiada
sul fiore di crisantemo
Yoshimine no Harutoshi (KKS, XI:470)
—
si scioglieva, inondata da una calda
e profonda tenerezza, come si scioglie la rugiada
sulle rose, quando riceve calore dai raggi dell’aurora
Apollonio Rodio (Argonautiche)
Il quinto e ultimo capitolo è infine interamente dedicato all’analisi del ruolo del vino e del sakè (rispettivamente negli ambienti del simposio e nella Corte Imperiale), affiancando alle poesie di autori come Alceo (VII-VI secolo a.C.) le waka di Ōtomo no Tabito (665-731) e Ōtomo no Sakanoue no Iratsune (700-750) e rinvenendo, così, nell’elevato simbolismo di queste bevande un’ulteriore chiave di lettura unificante.
Il saggio rappresenta, in ultima istanza, un prezioso strumento di analisi ed approfondimento per coloro che intendono comprendere se e quali siano i reali punti di contatto tra due civiltà – quella greca e quella giapponese – così diverse e lontane tra loro. «Le analogie, a volte sorprendenti, sono significative tanto quanto le radicali differenze» scrive la Cresci nella sua sintetica ma puntuale Prefazione, e non possiamo che trovarci concordi: il bel lavoro del Manuello ci permette di cogliere prossimità talvolta spiazzanti, leggendo gomito a gomito con i migliori poeti della storia piccoli segni di apertura che, a seconda della prospettiva, sono ora spiragli e ora abissi. Il minimo comune denominatore non è in questo caso (come si potrebbe essere indotti a credere) la sola brevità del testo, quanto piuttosto lo slancio – garbato o ruvido a seconda delle circostanze – verso una natura in continuo mutamento che trascina nel suo moto centrifugo anche l’uomo, da sempre schiavo del suo tempo.